Sanzionismo e proiezione nell’Indo-Pacifico: funzionerà? La strategia Usa deve fare i conti con sé stessa
2023-08-11 16:05:12
A maggio scorso il settimanale inglese The Spectator palesava quanto in Europa sembra abbastanza evidente ma è sconveniente dire pubblicamente: la guerra economica che Stati Uniti ed Unione Europea hanno ingaggiato con la Federazione Russa dopo l’inizio del conflitto ucraino è fallita. L’obbiettivo dichiarato era creare uno shock finanziario ed economico attraverso sanzioni e boicottaggi che costringesse il Cremlino alla resa. «L'Occidente –ha chiosato il settimanale inglese- si è imbarcato nella guerra delle sanzioni con un senso esagerato della propria influenza nel mondo». Dati alla mano, invece, pare che ad essere colpite siano state essenzialmente le aziende europee. Un recente studio del Financial Times, condotto su 600 bilanci e relazioni annuali di imprese europee presenti in Russia, ha mostrato una perdita di oltre 100 miliardi di euro. A questo dato vanno poi aggiunti gli impatti macroeconomici indiretti, come l’aumento del costo delle materie prime ed energetiche. Un evidente paradosso che invece, secondo alcuni analisti, è per Washington un rischio calcolato per ridurre la dipendenza di alcuni paesi dell’Europa occidentale (e soprattutto l’”asse carolingio” tra Germania e Francia) da Cina e Russia.
Ma l’uso della guerra economica non è una bizzarria recente delle classi dirigenti atlantiche. L’adozione del sanzionismo come strategia essenziale da parte americana ha una data precisa: il 6 ottobre 1917. In questa data venne infatti adottato il Trading with enemy act, con l’obbiettivo di limitare le capacità economiche della Germania e dotarsi di uno strumento in base al quale poter confiscare proprietà al nemico. Tre anni prima era stato il Parlamento del Regno Unito ad adottare, subito dopo il coinvolgimento nella Prima Guerra Mondiale, un provvedimento che vietava di fare affari con persone “nemiche”. Queste iniziative adottate in “tempi di guerra” restano valide anche in “tempi di pace”, per cui l’arma economica non è più strumento di guerra ma diviene una guerra con altri mezzi. Ne sa qualcosa il popolo cubano che da 61 anni subisce un embargo totale che non viene rimosso nonostante ogni anno l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a larghissima maggioranza, condanni questa pratica.

Nel corso di una recente riunione dei ministri delle Finanze del G7, la Segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen si è scagliata contro la presunta coercizione economica della Cina. È un termine molto usato anche qui in Europa, soprattutto nei circoli anticinesi. Ma chi è strutturalmente organizzato per esercitare una coercizione economica a danno di altri è l’America. Basti pensare al ruolo svolto dal Defense Production Act, una legge del 1950 che stabilisce come la struttura manifatturiera e commerciale degli Stati Uniti siano al servizio delle esigenze di guerra e del bisogno di difesa degli interessi nazionali. Una legge nata ai tempi della guerra di Corea ed ancora oggi in vigore è il Bureau of Industry of Security (BIS), un’agenzia del dipartimento del Commercio che sovraintende e sovra-ordina l’export nazionale, forzando le regole del commercio ed obbligando le imprese incluse delle liste del BIS a chiedere l’autorizzazione al governo statunitense prima di poter esportare un proprio prodotto. È per questa via che l’Amministrazione americana sta cercando di bloccare l’ascesa di colossi tecnologici cinesi, non concedendo più le licenze a nessun gruppo che esportava componenti americane alle aziende della Repubblica Popolare.
Questo tema introduce un punto centrale del sanzionismo americano e della vera coercizione economica, ossia l’extra-territorialità dell’applicazione di tali leggi, soprattutto in alcuni comparti come le filiere tecnologiche. L’esistenza di un vero e proprio mercato globale allarga de facto al mondo intero la pretesa americana dell’applicazione delle proprie leggi federali. Ed il caso Huawei ha dimostrato che i controlli sull’export riguardano tutte le catene di approvvigionamento. L’azienda di Shenzhen ha dovuto infatti sostituire più di 13.000 componenti nei suoi prodotti per superare blocchi e sanzioni commerciali statunitensi, ridisegnando inoltre 4.000 circuiti stampati. A questo si aggiunge una fortissima pressione e richiesta di scrutinio su ogni singolo componente. Per questa via viene colpito un valido competitor di aziende tecnologiche americane attraverso l’imposizione di costi a tutta la filiera produttiva.
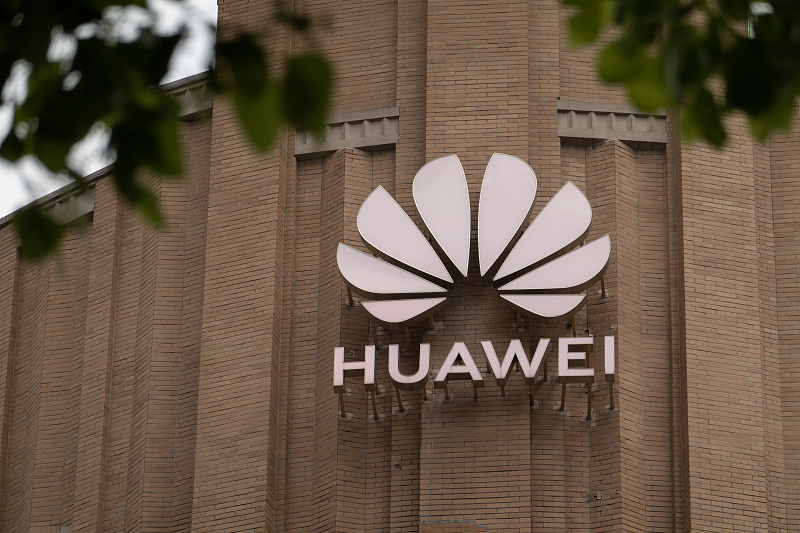
Una della più classiche forme di sanzionismo statunitense è quella dell’uso di disposizioni individuali verso persone fisiche, con la loro esclusione dai circuiti finanziari. Nel caso della Repubblica Popolare questa pratica si è allargata fino ad assumere la forma di un’esclusione sistematica per limitare l'ingresso di studenti universitari, specializzandi e ricercatori accusati, solo perché cinesi, di rubare i segreti della proprietà intellettuale americana. Una strategia destinata a scontrarsi con la realtà dei fatti che vede la ricerca in Cina crescere, motu proprio, a ritmi sostenuti. Se fino agli anni Ottanta Pechino pesava appena l’1% sul totale delle pubblicazioni scientifiche mondiali, oggi arriva a contare per il 16%. E per il futuro, soprattutto riguardo alla ricerca scientifica, la percentuale è destinata a crescere. Dalla metà dell’inizio del secolo la Cina è il paese al mondo che ha formato più dottori di ricerca in materie Stem: secondo uno studio del Center for Security and Emerging Technology, nel 2025 le università cinesi produrranno più di 77.000 dottorati Stem, rispetto ai circa 40.000 negli Stati Uniti. E se questi ultimi dovessero limitare ulteriormente gli scambi e le interazioni con gli studenti internazionali, il rapporto crescerebbe di 3 a 1.

Poiché l’Asia è la regione del mondo destinata a crescere significativamente sul piano economico e strategico gli Stati Uniti hanno concentrato qui le proprie attenzioni, a partire dal progetto del Pivot to Asia dell’Amministrazione Obama, che esplicitava una massiccia proiezione (militare, politica ed economica) nell’Asia Pacifico. Tale area di azione si è in seguito trasformata in quella che dal biennio 2021-22 è diventato l’Indo-Pacifico, nel tentativo esplicito di coinvolgere l’India nei piani di contenimento della Cina, attraverso una piattaforma per la cooperazione in campo economico, scientifico e militare. Le iniziative diplomatiche che fanno perno sul concetto di Indo-Pacifico riguardano sia la sicurezza militare, come il Quadrilateral Securty Dialogue (Quad) e l’Aukus, sia l’integrazione economica, in particolare l’Indo-Pacific Economic Framework (Ipef) che si inserisce in un ambito già interessato dalla Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) e dalla Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (Cptpp).
Tale strategia palesa chi adotta la coercizione economica sul piano internazionale, ma soprattutto apre interrogativi sulla tenuta interna di tale strategia. Gli Stati Uniti corrono il rischio di uno scollamento tra le ragioni della sicurezza nazionale e quelle degli interessi economici, a partire dal bisogno a delocalizzare altrove la produzione, sviluppare ricerca con altri paesi e non limitare le capacità commerciali delle proprie imprese. Cosa può accadere se, ad un certo punto, gli interessi economici vanno in una direzione e quelli strategici in un’altra? È un interrogativo che, con l’avvicinarsi delle presidenziali 2024, diventa dirimente.
L'autore Francesco Maringiò è il presidente dell’Associazione italo-cinese per la promozione della Nuova Via della Seta








